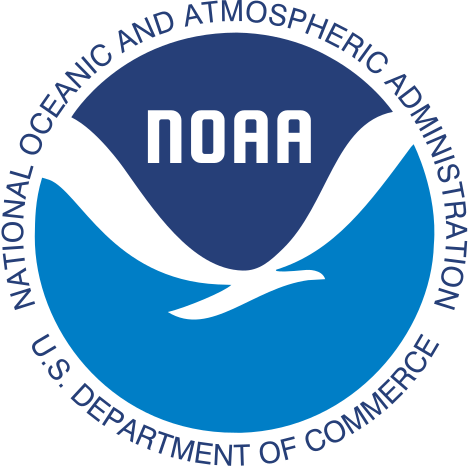La scienza ha sempre cercato di rispondere alle più incredibili curiosità umane usando poche ma solide basi da cui partire. Adesso grazie al pensiero scientifico possiamo affermare di aver compreso a grandi linee la nascita e perfino la morte futura dell’Universo, la nascita del Sistema Solare, fino a quando il Sole si spegnerà in una piccola nana bianca tra circa 5 miliardi di anni 1.
Grazie agli studi paleontologici, biologici, chimici e fisici, siamo riusciti a ricostruire tutta la cronistoria della Terra, da quando era un polveroso sasso senza vita fino al meraviglioso mondo che è oggi.
Eppure gli scienziati non sono ancora sazi di sapere – d’altronde è bene che non lo siano mai, ci sono quelli che si domandano cosa c’era prima del Big Bang 2 o se possono esistere universi paralleli e come questi potrebbero essere.
Gary R. Huss invece si domanda più prosaicamente: quale tipo di stella ha dato origine alla nebulosa che ha creato il nostro sistema solare?
Questa può sembrare una domanda irrisolvibile ma invece la soluzione è molto più banale di quanto si pensi.
Analizzando le rocce terrestri, marziane, lunari e meteoriche è stato possibile per gli scienziati di farsi un’idea abbastanza precisa sull’abbondanza di certi elementi chimici piuttosto che altri nel sistema solare.
Senza scendere nel tedioso particolare sulle analisi dei rapporti tra i vari isotopi e radionuclidi 3 4 sparsi nei più vari campioni analizzati e conoscendo abbastanza bene i meccanismi della fusione nucleare che alimentano le stelle e che producono gli atomi più complessi di cui siamo composti, si possono calcolare quali tipi di reazione nucleare possono dar luogo a certe abbondanze.

L’immagine composita del resto di supernova G299.2-2.9. L’ampiezza della struttura è di circa 114 anni luce (Crediti: X-ray: NASA/CXC/U.Texas/S.Park et al, ROSAT; Infrared: 2MASS/UMass/IPAC-Caltech/NASA/NSF).
Appunto studiando quali radionuclidi a vita breve 5 presenti all’inizio della storia del Sistema Solare 6 e la loro abbondanza relativa rispetto ai radionuclidi a vita lunga come l’uranio 238, il torio 232, il potassio 40 e così via, si può tentare di ricostruire la composizione chimica della nebulosa che dette origine al nostro sistema solare, primo e fondamentale passo per sapere cosa ci sia stato prima, ovvero quali potrebbero essere state le caratteristiche della stella – o stelle – che ha prodotto tutti gli elementi chimici più pesanti dell’idrogeno di cui tutti noi siamo costituiti.
Studiando i vari tipi di sintesi nucleare nei diversi casi di evoluzione stellare che arrivano a produrre i radionuclidi cercati, si è potuto stabilire che la massa limite va da 1 a 120 masse solari, un po’ vago come limite ma è già qualcosa.
Ma è possibile per una singola stella produrre i radionuclidi a vita breve scoperti nel sistema solare?
È poco probabile che una stella con una massa compresa tra le 20 e le 60 masse solari o una stella di massa intermedia del ramo asintotico delle giganti (AGB 7) sia la responsabile dei radionuclidi osservati.
Piccole stelle AGB non possono produrre abbastanza ferro 60. Una supernova di tipo II originata da una stella con una massa iniziale superiore a 20 masse solari produrrebbe troppo ferro 60 e troppo magnesio 53. Altre fonti come potrebbero essere novae, supernovae di tipo Ia, o il collasso del nucleo di una supernova O-Ne-Mg 8 o nane bianche non sembrano in grado di produrre radionuclidi a vita breve come quelli osservati nelle giuste proporzioni.
A questo punto la conclusione più probabile è che non sia stata una singola stella a generare la materia nebulare primordiale nelle proporzioni isotopiche rilevate, ma almeno due: una supernova di tipo II di massa inferiore o uguale a 11 masse solari e un’altra – probabilmente una stella di massa compresa tra 12 e 25 masse solari – che insieme hanno fornito gli elementi osservati all’incirca nelle proporzioni osservate.

Gary R. Huss. Ricercatore e direttore del laboratorio di chimica cosmica WM Keck – Credit: Istituto di Geofisica e Planetologia delle Hawaii.
Il traguardo che si è dato Gary Huss non è affatto semplice: ci possono essere stati molti processi che hanno potuto alterare in seguito il rapporto degli isotopi osservati nel sistema solare: la fase di preaccenzione del nostro Sole ha generato flussi di raggi X in grado di alterare molti rapporti isotopici, l’influenza dei raggi cosmici, e mille altri processi radiativi possono aver scombussolato il quadro originario della nebulosa primordiale.
Il suo sarà un lavoro terribilmente difficile ma che potrà dare immense soddisfazioni.
Comunque sarà bello scoprire che anche il Sole ha avuto due genitori.
Note: