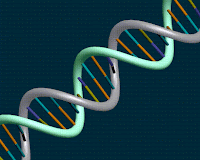Non sono certo David Malin. In verità sono anche poco bravo nelle materie artistiche, comunque nel mio piccolo ci provo. Pochi mezzi – e poveri, poco tempo a disposizione ma tanta volontà di ottenere qualche risultato. Questa è la vera etica hacker, quella che è nata nell’Homebrew Club e io cerco di applicarla ovunque posso.
 . .Credit: Il Poliedrico |
| Dati Exif dell’immagine | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vedete le due immagini qui sopra? Sono lo stesso soggetto, lo stesso fotogramma prima (a sinistra) e dopo l’elaborazione al computer (a destra). La fotografia è banale: a sinistra nell’imagine è visibile la costellazione Orione, al centro l’ammasso aperto più vicino alla Terra – appena 150 anni luce – delle Iadi con la gialla Aldebaran in primo piano 1, poi le stranote Pleiadi e la congiunzione Giove – Venere di cui ho parlato nei giorni scorsi.
Però questa volta non mi sono limitato alla semplice correzione del fondo cielo come ho descritto in un altro articolo 2, stavolta ho cercato di applicare una mia rivisitazione di un metodo che ho appreso da una rivista di astronomia piuttosto nota 3.
Un grosso limite dell’astrofotografia è proprio nella sensibilità del sensore: quello che infatti sembra essere un grande vantaggio, cioè la capacità di sommare aritmeticamente la luce incidente in un singolo pixel che consente di registrare anche le sorgenti più deboli con pose abbastanza lunghe, per i colori rappresenta un limite importante. Non importa che la luce sia rossa, verde o blu, quando il pixel è saturo appare comunque bianco qualunque sia la lunghezza d’onda della luce incidente nel pixel. Nell’astrofotografia più professionale si usano sensori CCD con un ampio spettro di sensibilità in bianco e nero insieme a filtri ottici colorati -verde, rosso e blu – e le immagini vengono unite in fase di elaborazione restituendo così la dinamica di colore originale.
Ma come fare lo stesso con una reflex entry-level, un mini grandangolo 18-55 e un treppiedi cinese?
In pratica ho fatto due riprese: una perfettamente a fuoco e una seconda volutamente fuori fuoco, dove al posto delle stelle puntiformi adesso erano presenti dei cerchietti della luce diffusa dalle sorgenti più brillanti.
Per prima cosa ho convertito dai RAW le immagini in un formato più maneggevole, in questo caso il JPEG, ma confido che col BMP o il TIFF – che sono formati non compressi – potrei ottenere risultati anche migliori, questa era soltanto una prova 4.
Con l’immancabile Gimp 2.6 poi ho corretto il fondo cielo come già descritto alle due immagini e ho sfocato con un algoritmo gaussiano l’immagine sfocata facendo in modo che le sagome dei cerchietti di luce sfumassero dolcemente nel fondo cielo.
Poi ho sommato questa in primo piano all’immagine a fuoco – mantenuta in secondo piano usando la tecnica dei livelli – e ho giocato con la trasparenza del livello per ottenere il migliore risultato visibile.
Il risultato già buono però mostrava ancora una forte spillatura delle sorgenti puntiformi rispetto al loro sfondo colorato, questo perché gli oggetti a fuoco erano ancora troppo piccoli e saturi per una buona resa artistica.
Anche in questo caso i filtri gaussiani di Gimp si sono rivelati essenziali. Dopo aver centrato la falsa doppia θ Tau 5 ho cercato di sfumare le sorgenti puntiformi cercando comunque di non fondere la luce di θ Tau in una chiazza indistinta.
Dopo aver fuso tutti i livelli ho leggermente intensificato la luce delle stelle senza cercare di rovinare tutto: et voilà, le stelle ora hanno il loro colore 6!