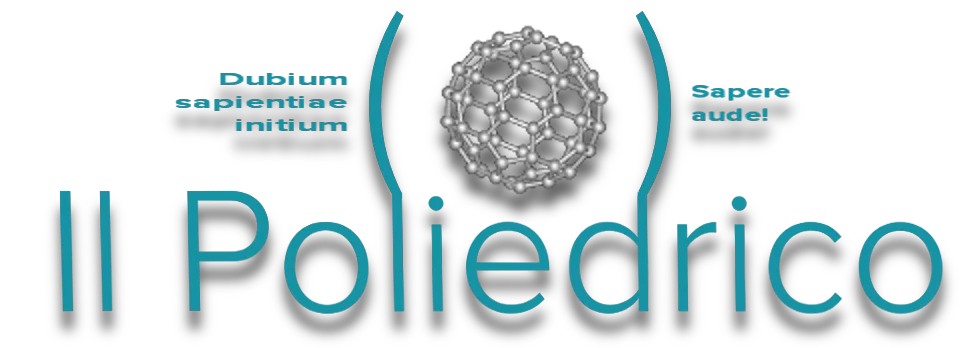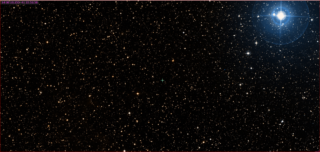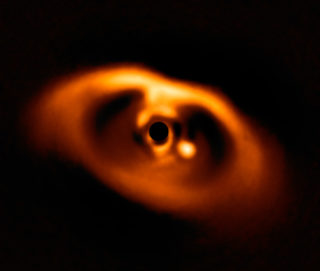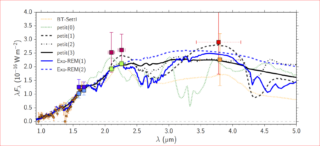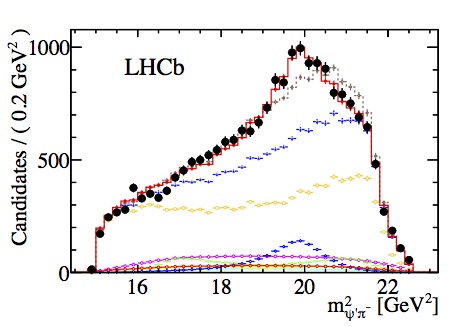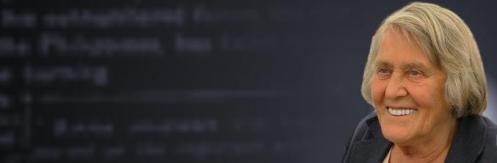La copertina del mio libro: anche la fotografia qui è mia. Su Amazon si può leggere sia la sinossi che un breve estratto gratuito.
Ho sempre sostenuto che nell’affrontare un argomento tanto complesso non si dovrebbe mai prescindere dal raccontare anche le condizioni che lo circondano, esattamente come per lo scrivere, o il parlare, occorre conoscere il significato di ogni singola parola usata. Mi è altrettanto caro però anche un altro concetto: un libro non serve a dare esclusivamente nozioni, ma deve offrire al lettore anche qualcosa su cui riflettere e proporre di approfondire autonomamente l’argomento di cui tratta.
Per questo saggio[1] a me sono serviti quattro anni. O forse anche di più.
Sicuro che il primo embrione di quello che poi sarebbe diventato il mio primo libro — non ho affatto intenzione di fermarmi a questo, uscì proprio su questo Blog nel 2015[2], attraverso una serie di articoli sul celebre Paradosso di Fermi. Non sto a ripeterne qui la storia, l’ho spiegata in un capitolo del mio lavoro.
Ho detto quattro anni, perché ne parlai durante un pranzo con la Responsabile della Didattica e Divulgazione presso la Fondazione GAL Hassin-Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche, Isnello (PA), (blogger di Tutti Dentro , firmatrice di diversi articoli qui ospitati, nonché mia carissima amica) Sabrina Masiero nel lontano 2016, e che poi mi ha aiutato tantissimo proprio nelle ultime revisioni alla fine dello scorso anno.
È stata una genesi lunga che alla fine mi ha portato molto lontano — e non solo da queste pagine — e fatto maturare in modi che, sinceramente, non avrei mai creduto possibile. Ho rivisto alcune mie posizioni, affrontato argomenti e campi a me del tutto sconosciuti o appena osservati da lontano.
Esplorare le innumerevoli domande insite in questo saggio è virtualmente impossibile, perché ognuna di esse apre infiniti altri quesiti che richiederebbero altrettanti trattati. Per questo ne ho scelti e affrontati soltanto qualcuno. Una scelta difficile, che mi ha portato a scrivere e abbandonare centinaia di bozze e sviluppare quelle che ho comunque ritenuto più significative.
Affrontare i temi della Vita, Intelligenza e Civiltà extraterrestri prendendo spunto unicamente dall’umana esperienza su questo mondo può sembrare scontato, ma molto spesso tale sforzo non viene compiuto.
Duecento o quattrocento miliardi di stelle nella nostra Galassia non significa che ognuno di quei soli sia accompagnato da qualche forma di vita, anche se appena batterica. Anzi: la maggior parte delle stelle che vediamo ad occhio nudo (appena qualche migliaio) o è troppo grande oppure possiede qualche altro handicap da scontare.
Eppure tra queste centinaia di miliardi si possono ancora calcolare milioni di altre stelle che potrebbero benissimo ospitare altrettante terrificanti e pur sempre meravigliose forme di vita; queste potrebbero funzionalmente somigliare ad alcune di quelle che la Terra ha ospitato in quattro miliardi di anni, oppure no.
Come è esattamente sorta la vita sulla Terra ancora nessuno lo sa, ma ci sono buoni e ragionevoli motivi per pensare che questo sia accaduto — e che accada ancora — attorno a quei milioni di stelle che ho appena citato, e questo lo si è creduto o, perlomeno sospettato, fin dalla preistoria.
Il concetto stesso di Vita ha mutato significato nei secoli e con esso anche il modo in cui si è supposto che la Vita sarebbe potuta emergere. Dall’aristotelica abiogenesi alla sua definitiva smentita da parte di Pasteur, dal concetto fumoso di Erasmus Darwin (il nonno di Charles) fino agli esperimenti di Miller e Urey[3] che hanno spianato poi la strada alla moderna astrobiologia.
Ma quello che — almeno per me, amante da sempre del razionalismo scientifico — è apparso sempre più evidente, man mano che andavo avanti con la stesura, è stata la similitudine tra il concetto metafisico del Divino e quello dell’Universo e la sua storia che faticosamente stiamo scoprendo nel’ultimo secolo.
Deus sive Natura, diceva più di tre secoli fa il filosofo olandese Baruch Spinoza, Dio ossia la Natura. E l’implicito che qui in parte tento di mostrare è simile: tutta la storia dell’Universo che abbiamo ricostruito ci mostra che sotto molti aspetti il Divino e la Natura possono essere concetti piuttosto simili e spesso essere perfino sovrapponibili. Col mio studio desidero soltanto offrire alcuni spunti su cui riflettere partendo da una domanda fatta per celia all’ora di pranzo dal grande fisico che fu Enrico Fermi e che è matematicamente riassunta nell’Equazione di Francis Drake.
Come ogni buon libro che si rispetti, ho chiesto a Marco Castellani, dell’Osservatorio Astronomico di Roma – INAF, blogger di Gruppo Locale e scrittore, di curare la prefazione del mio lavoro. Ne è sortita una piccola perla che merita di essere gustata per intero, perché anch’essa offre al lettore miriadi stimoli di riflessione.
Non voglio svelare di più per non rovinarvi il gusto della lettura del mio saggio, ma posso dirvi che per me è stato un viaggio meraviglioso e che spero, con l’approvazione di voi lettori, presto di rifare.
Cieli sereni.