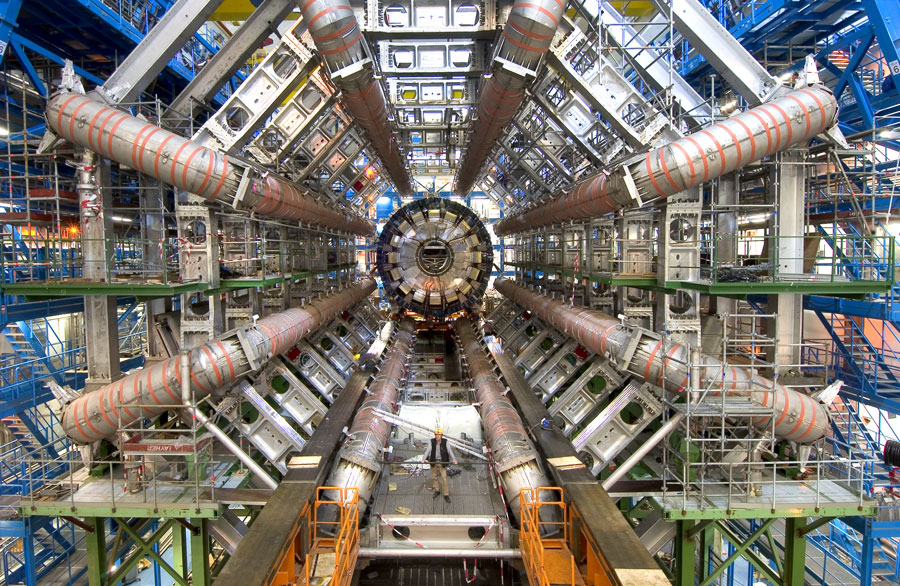Questa è davvero la celebre domanda da un milione di dollari o, se preferite visto che siamo in Europa, un milione di euro. Non è davvero facile rispondere, solo le prossime ricerche ci potranno dire da quale parte guardare. Ma il progresso scientifico va avanti così, per tentativi ed errori. Fra Premi Nobel dati per scoperte che domani potrebbero essere superate per il medesimo meccanismo di autorevisione che li aveva distribuiti.
Questo giusto per ricordarci quanto sia incerto il pensiero umano che si dedica alle scoperte del Cosmo dove l’unica certezza è sapere di non essere certi di sapere abbastanza.
 Nel 2011 Brian P. Schmidt e Adam Riess vinsero il Premio Nobel per la Fisica per aver scoperto che l’Universo stava accelerando la sua espansione al contrario di quanto fino ad allora era stato creduto. Il perché questo accada non è mai stato chiarito del tutto ma finora tutto suggerisce che sia la conseguenza di una costante cosmologica, indicata con la lettera greca Λ, capace di contrastare il collasso gravitazionale del contenuto dell’Universo. Già in passato mi sono cimentato nello spiegare per sommi capi come questa costante operi nel Modello Standard ΛCDM (Lambda Cold Dark Matter) [cite]https://ilpoliedrico.com/2016/07/zenone-olbers-lenergia-oscura-terza-parte.html[/cite] e quindi non credo sia opportuno tornarci sopra, ma di fatto tutto indica che una condizione di universo accelerato sia legata anche allo stato di falso vuoto che permette l’esistenza stessa della materia e di conseguenza la nostra di osservatori.
Nel 2011 Brian P. Schmidt e Adam Riess vinsero il Premio Nobel per la Fisica per aver scoperto che l’Universo stava accelerando la sua espansione al contrario di quanto fino ad allora era stato creduto. Il perché questo accada non è mai stato chiarito del tutto ma finora tutto suggerisce che sia la conseguenza di una costante cosmologica, indicata con la lettera greca Λ, capace di contrastare il collasso gravitazionale del contenuto dell’Universo. Già in passato mi sono cimentato nello spiegare per sommi capi come questa costante operi nel Modello Standard ΛCDM (Lambda Cold Dark Matter) [cite]https://ilpoliedrico.com/2016/07/zenone-olbers-lenergia-oscura-terza-parte.html[/cite] e quindi non credo sia opportuno tornarci sopra, ma di fatto tutto indica che una condizione di universo accelerato sia legata anche allo stato di falso vuoto che permette l’esistenza stessa della materia e di conseguenza la nostra di osservatori.
Per comprendere meglio come si è arrivati a capire che l’espansione dell’Universo sta accelerando, prendiamo ad esempio una SNa che con le dovute correzioni del caso, mostri uno spostamento verso il rosso (redshift) z di circa 0.1, pari a circa il 10% dell’età dellUniverso (≈1.38 miliardi di anni). Per una distanza così – relativamente – piccola la luminosità apparente osservata nelle SNe è in linea con il loro redshift e quanto prevede la normale Legge di Hubble. Per le distanze maggiori, supponiamo z≈0.5 (23 dell’età dell’Universo) si osserva che la luminosità delle SNe 1a è più bassa del redshift indicato dal loro spettro. Questo indica che nel corso del tempo l’espansione dell’Universo è cambiata e che pertanto l’affievolimento della luce delle SNe risulta più marcato e che devia dalla linearità della Legge di Hubble in funzione del tempo trascorso. In soldoni, l’Universo si stava espandendo più lentamente in passato di quanto lo faccia oggi. La luce emessa quando l’Universo aveva 23 dell’età attuale ha dovuto percorrere più spazio per raggiungerci e quindi è più debole di quanto previsto dai modelli di universo senza alcuna costante cosmologica.
L’altro giorno però, uno studio apparso su Scentific Reports di Nature [cite]http://www.nature.com/articles/srep35596[/cite] sembrava rimettere in discussione che l’espansione dell’Universo stesse accelerando. In realtà non è proprio così, il senso dell’articolo a mio avviso non è stato compreso del tutto e di conseguenza anche la notizia è stata distorta.
In pratica gli autori della ricerca, tra cui figura anche l’italiano Alberto Guffanti dellUniversità di Torino, hanno suggerito che in base a un nuovo campione di 740 supernovae (SN) del tipo 1a 1 non possono esserci prove evidenti che l’espansione dell’Universo sta accelerando e che le nuove loro analisi sono consistenti piuttosto con un modello di espansione costante.
Gli altri studi che confermano l’attuale modello ΛCBM

Anisotropie di temperatura nella CMBR (± 200 microKelvin) rilevate dal satellite WMAP. Queste microvariazioni nella densità della materia sarebbero all’origine degli ammassi di galassie. La loro dimensione paragonata alle dimensioni degli ammassi di galassie successivi mostra che l’espansione dell’Universo sta accelerando.
Così, giusto per chiarire, che l’espansione dell’Universo stia accelerando non sono solo le misure fotometriche delle diverse supernovae a dirlo. Dall’anno della scoperta del fenomeno, il 1998, gli astronomi hanno cercato, e trovato, altre prove indipendenti a sostegno di questa tesi [cite]https://arxiv.org/abs/astro-ph/0604051v2[/cite], mentre nuove misure e ricalibrazioni delle candele standard suggeriscono che l’accelerazione potrebbe essere ancora più accentuata [cite]https://arxiv.org/abs/1604.01424[/cite].
Spiegare nel dettaglio ognuno di questi porterebbe troppo lontano. Una di queste fa riferimento alle dimensioni dell’impronta delle oscillazioni acustiche dei barioni rilevate nella radiazione cosmica di fondo (CMBR) 2 e alla distribuzione delle dimensioni degli ammassi di galassie nel corso del tempo [cite]http://iopscience.iop.org/article/10.1086/466512/[/cite].
Altre conferme dell’attuale modello ΛCBM provengono dalla distribuzione di massa degli ammassi di galassie e perfino dal calcolo dell’età del1l’Universo [cite]https://arxiv.org/abs/1204.5493[/cite] [cite]http://www.cambridge.org/it/academic/subjects/astronomy/cosmology-and-relativity/formation-structure-universe[/cite].
Il nuovo studio

L’effettto Sachs-Wolfe integrato. Questo meccanismo potrebbe essere invocato per spiegare l’arrossamento locale della luce per effetto della gravità.
Credit: Istituto di astronomia dell’Università delle Hawaii
In realtà i ricercatori affermano appunto che stando alle loro ricerche basate su un numero molto maggiore di SNe le analisi – interpretate col modello attuale, quindi quello di un universo descritto per comodità di calcolo come esattamente omogeneo e che si comporta come un gas ideale, tenetelo a mente – dei dati indicano che esse non potrebbero fornire una prova certa dell’attuale modello. Gli amanti della statistica potrebbero trovare interessante che la distribuzione delle probabilità descritte da questo studio che questo Universo si trovi in uno stato di espansione accelerata è ≲ 3 σ (circa lo stesso o di poco minore ai 3 sigma).
Se questa ricerca fosse confermata, in proposito lo strumento CODEX presso l’European Extremely Large Telescope (E-ELT) dovrebbe poter presto indicare dove e cosa cercare, si aprirebbero nuove possibilità: come spiegare che le fluttuazioni acustiche dei barioni nella CMBR che riflettono quello che osserviamo oggi nell’Universo? E la distribuzione della massa degli ammassi di galassie? Un modello interessante per spiegare alternativamente quello che osserviamo nella luce delle SNe è l’effetto Sachs-Wolfe integrato [cite]https://ilpoliedrico.com/2012/09/energia-oscura-e-anisotropia-nella-radiazione-cosmica-di-fondo.html[/cite], un arrossamento della luce causato dalla curvatura locale dello spazio dovuta alla gravità.
Questa chiave di lettura porterebbe inevitabilmente al ripensamento dei modelli di universo non più intesi come oggetti esattamente omogenei e isotropi ma più come spazio vuoto con un ruolo più marcato della componente massa/energia a livello locale. Gli autori della ricerca in fondo questo dicono: il modello a CDM corretto per tenere conto della componente repulsiva attribuita all’energia oscura e indicata come costante cosmologica Λ è vecchio e sorpassato dalle nuove scoperte e conoscenze. È ora che esso venga ripensato.