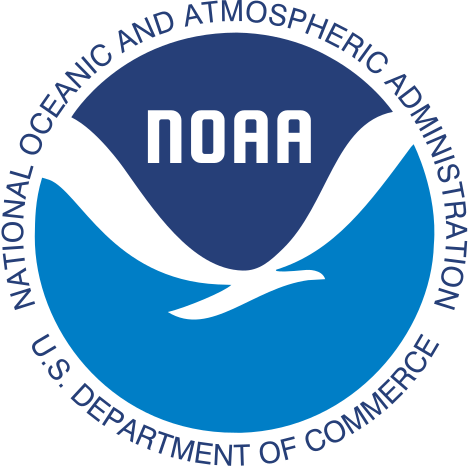La scorsa settimana ho partecipato a una conferenza presso la Facoltà di Fisica dell’Università di Siena sui pianeti extrasolari tenuto dalla mia carissima amica – e collaboratrice di questo blog – Sabrina Masiero. Non sto a raccontare la cronaca dell’incontro, spero che presto sia disponibile l’intero filmato dell’evento, ora voglio parlare di qualcos’altro.
La scorsa settimana ho partecipato a una conferenza presso la Facoltà di Fisica dell’Università di Siena sui pianeti extrasolari tenuto dalla mia carissima amica – e collaboratrice di questo blog – Sabrina Masiero. Non sto a raccontare la cronaca dell’incontro, spero che presto sia disponibile l’intero filmato dell’evento, ora voglio parlare di qualcos’altro.
Sabrina è rimasta ospite qui a Siena per l’intero fine settimana, così che abbiamo avuto modo di parlare a lungo. È emerso come purtroppo spesso il ruolo di divulgazione sia considerato marginale rispetto all’altrettanto importante ruolo di ricercatore. Ovvio, fare ricerca significa accedere a fondi economici importanti, accedere a strutture all’avanguardia e progettarne di nuove; scrivere pubblicazioni, fare nuove scoperte e perché no, aspirare ad incarichi e vincere premi prestigiosi.
Vero, indubbiamente vero se si guardano le soddisfazioni personali, fare ricerca scientifica è indubbiamente gratificante, ma quella è solo la punta dell’iceberg di cosa è la scienza.
La ricerca fine a sé stessa finisce per essere autoreferenziale, oserei dire quasi inutile. È come scoprire un immenso tesoro e non poterlo portar via al sicuro; come scoprire un metodo banale per produrre diamanti in casa ma non poterlo usare perché altrimenti il loro valore di mercato crollerebbe a zero. La ricerca deve sempre essere accompagnata da una efficace opera di divulgazione, altrimenti non ha senso.
 Qualche volta vengono portati alla mia attenzione opere d’ingegno di persone che – in buona fede – credono che la fisica in qualche punto è fallata e che vada riscritta, o che, secondo loro, dovremmo aspettarci un certo risultato piuttosto che un altro in un particolare esperimento. Qualche volta trovo le loro domande legittime e degne di attenzione e altre volte, ben più spesso, mi accorgo che sono ragionamenti senza capo né coda, dove spesso si confonde la causa con l’effetto, si usano concetti assolutamente diversi ed estranei al loro contesto (un po’ come spiegare il Teorema di Pitagora con le leggi del moto lineare) e così via. Questi episodi, lungi da me causare ilarità o qualche risentimento, mi dicono invece la desolante realtà per quel che è. Mostrano che esistono persone dotate di senso critico e di passione ma che purtroppo non hanno le basi per poter giungere a qualcosa di coerente. A loro sono venute a mancare le fondamenta su cui si regge la scienza, la comunicazione e l’apprendimento. In parte accuso il sistema scolastico che qui, a parte poche eccezioni, pare schiacciato più sull’apprendimento mnemonico alla vecchia maniera che pensato per sviluppare un pensiero scientifico critico, finendo per scoraggiare tanti giovani studenti. Ma condanno senza appello anche il cortocircuito provocato di chi si balocca con l’autoreferenzialità delle sue posizioni, del “io so’ io e voi non sapete un …” di tanti soloni di cui ho accennato anche in un altro precedente pensiero [cite]http://ilpoliedrico.com/2016/04/la-fusione-dei-ghiacciai-campanilismo-antiscientifico.html[/cite].
Qualche volta vengono portati alla mia attenzione opere d’ingegno di persone che – in buona fede – credono che la fisica in qualche punto è fallata e che vada riscritta, o che, secondo loro, dovremmo aspettarci un certo risultato piuttosto che un altro in un particolare esperimento. Qualche volta trovo le loro domande legittime e degne di attenzione e altre volte, ben più spesso, mi accorgo che sono ragionamenti senza capo né coda, dove spesso si confonde la causa con l’effetto, si usano concetti assolutamente diversi ed estranei al loro contesto (un po’ come spiegare il Teorema di Pitagora con le leggi del moto lineare) e così via. Questi episodi, lungi da me causare ilarità o qualche risentimento, mi dicono invece la desolante realtà per quel che è. Mostrano che esistono persone dotate di senso critico e di passione ma che purtroppo non hanno le basi per poter giungere a qualcosa di coerente. A loro sono venute a mancare le fondamenta su cui si regge la scienza, la comunicazione e l’apprendimento. In parte accuso il sistema scolastico che qui, a parte poche eccezioni, pare schiacciato più sull’apprendimento mnemonico alla vecchia maniera che pensato per sviluppare un pensiero scientifico critico, finendo per scoraggiare tanti giovani studenti. Ma condanno senza appello anche il cortocircuito provocato di chi si balocca con l’autoreferenzialità delle sue posizioni, del “io so’ io e voi non sapete un …” di tanti soloni di cui ho accennato anche in un altro precedente pensiero [cite]http://ilpoliedrico.com/2016/04/la-fusione-dei-ghiacciai-campanilismo-antiscientifico.html[/cite].
È qui che il ruolo di divulgatore scientifico – come il mio con questo modesto blog e quello di Sabrina per conto dell’INAF – entra in gioco. Saper parlare di scienza ad un pubblico non specialistico è fondamentale. Vuol dire creare quell’anello di congiunzione tra la ricerca scientifica più avanzata e il pubblico. Significa saper capire il linguaggio spesso criptico dei ricercatori e di adattarlo senza stravolgimenti in qualcosa di comprensibile alle persone comuni. l’astronomo americano Carl Sagan e uno dei fondatori del Progetto SETI, divenne noto presso il grande pubblico per il suo libro Cosmos che era la trascrizione letterale di una serie televisiva di documentari per la PBS da lui condotta. Egli era un valente divulgatore, grazie al suo impegno valenti scienziati come Neil deGrasse Tyson sono venuti fuori e tanti altri meno noti hanno intrapreso una carriera scientifica arricchendo così tutta l’umanità.
Saper parlare e decidere di parlare di scienza è essenziale perché la scienza non sia percepita come il male e gli scienziati non siano visti come sciamani. Parlare di scienza significa dare alle persone la capacità di ammutolire gli stolti che oggi predicano contro i vaccini o che vendono acqua zuccherata a peso d’oro con la forza della ragione ma anche gli strumenti per comprendere quello che è vero dal falso, come le bischerate delle scie chimiche rilasciate dagli aerei. Significa trasmettere il testimone della curiosità scientifica alle nuove generazioni, nuovi ricercatori e divulgatori di domani, come il Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Siena Alessandro Marchini sta facendo con i ragazzi delle scuole superiori di qui.
Quindi non penso che essere divulgatori sia un ruolo secondario nella scienza, anzi è vero il contrario, e del compito che mi sono ritagliato ne sono fiero.
Tag: importanza
L’importanza di una eclisse

Credit: Jonathan Sabin - Ellenton, Florida
Sono passati ben 372 anni dall’ultima volta che c’è stata una eclisse totale di Luna durante il solstizio d’inverno, peccato che non sia stata visibile dal nostro paese, se non per pochi minuti prima dell’alba, cielo permettendo. Per questo non me la sono sentita di scrivere qualcosa in merito per annunciare un fenomeno che con tutta probabilità non sarebbe forse nemmeno notato.
Vorrei solo sottolineare l’importanza delle osservazioni visuali, e ovviamente fotografiche, di un evento tutto sommato abbastanza banale.
Come ha sottolineato anche l’ottimo sito spaceweather, è importante l’osservazione anche solo visuale di una eclissi di Luna. Le informazioni che si possono ricavare dal colore e dalla Luminosità della Luna in ombra sono un indice preziosissimo sulla qualità della nostra stratosfera.
Infatti, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, la Luna non scompare mai del tutto, come ci si aspetterebbe da un corpo che entra in un cono d’ombra, specie se questo cono d’ombra è proiettato dalla Terra stessa. La nostra atmosfera diffonde la luce solare nel nostro cono d’ombra all’altezza della Luna rendendola comunque visibile, anche se arrossata, più o meno per lo stesso fenomeno che rende rosso il Sole all’orizzonte.
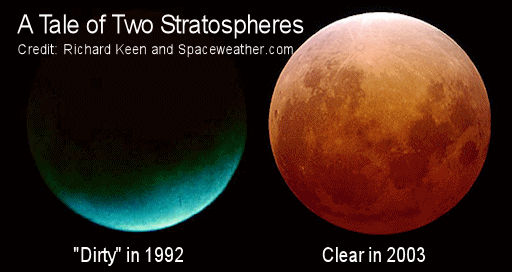 Quando qli strati più alti della nostra atmosfera sono più sporchi, come ad esempio dopo un’eruzione vulcanica, la qualità e la quantità di luce diffusa cambia, e più la nostra atmosfera è opaca, meno luce viene diffusa e meno luminosa è la Luna durante l’eclisse.
Quando qli strati più alti della nostra atmosfera sono più sporchi, come ad esempio dopo un’eruzione vulcanica, la qualità e la quantità di luce diffusa cambia, e più la nostra atmosfera è opaca, meno luce viene diffusa e meno luminosa è la Luna durante l’eclisse.
Per il professore Richard Keen dell’Università del Colorado, l’effetto dell’eruzione del Pinatubo del 1992 che inondò l’atmosfera di milioni di tonnellate di polveri e gas, provocò un abbassamento globale di temperatura di qualche decimo di grado rendendo più opaca l’atmosfera ai raggi del Sole e le eclissi di Luna più oscure.
Quindi le riprese di questa eclisse del 21 dicembre scorso indicano una atmosfera abbastanza limpida, nonostante la famosa eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajokull che mise in all’erta i cieli di tutta Europa nei mesi di marzo e aprile scorsi.
Quindi è importante l’osservazione visuale dei fenomeni celesti, come per esempio le eclissi, o le piogge di meteore, o le comete quando è possibile. Come vedete anche da una banalità come l’intensità di un cono d’ombra può dare più informazioni di tanti articoli di giornale sullo stesso fenomeno, che si limitano alla cronaca dell’evento, come invece mi sforzo di fare attraverso questo Blog.
Dimenticavo: per chi ha voglia di godersi alcune immagini dell’eclissi di Luna del 21 dicembre 2010 può trovarle a questo indirizzo.
L’importanza di un nucleo fuso
Le stelle simili al Sole, per quanto stabili e costanti possano essere, hanno la peculiarità di attraversare ciclicamente fasi di turbolenza superficiale che sfociano in spettacolari eruzioni di materia dalla fotosfera e dalla corona. Sono comunque dispersioni di materia di quantità estremamente piccola in proporzione alla notevole massa della stella e assolutamente ininfluenti per la stella, ma non per i pianeti che la circondano.
Abbiamo visto in un precedente articolo come agli albori del nostro sistema solare il Sole si sia spogliato della polvere e gas che lo circondava durante la fase chiamata T Tauri, dal nome della stella che per prima è stata studiata in questa fase.
Questa fase spogliò anche i pianeti più interni delle loro prime atmosfere, compresa la Terra che in quei momenti si stava formando. Ora il Sole non è più così esuberante, ormai è quasi un signore di mezza età, ma continua con i suoi ruttini al plasma un po’ come fanno tutte le altre stelle sue simili.
| Il nucleo della Terra si formò quando si formò la Luna, la Terra era più piccola e probabilmente non ancora del tutto differenziata nelle sue parti interne quando si scontrò con un corpo analogo grande circa quanto Marte. L’impatto fuse completamente di nuovo la giovane Terra permettendo la genesi del suo enorme nucleo ferroso e proiettando il materiale più leggero in orbita dove questo si sarebbe ricondensato formando la Luna |
Con la scoperta via via dell’esistenza di altri pianeti extrasolari rocciosi c’è chi si è chiesto [cite]https://arxiv.org/abs/1010.5133[/cite] se questi potessero sostenere un campo magnetico analogo a quello terrestre in grado di proteggere la vita che possa essersi generata sulla superficie del pianeta.Alla Terra questa attività stellare non dà quasi più alcun fastidio, grazie al suo magnifico nucleo di ferro fluido che genera un immenso campo magnetico planetario in grado di proteggerla dalle radiazioni del vento solare e da qualche bolla di plasma che ogni tanto viene emessa dal Sole ormai da quasi 5 miliardi di anni. Se non fosse per il suo campo magnetico la Terra non sarebbe un buon posto per viverci, la sua superficie sarebbe costantemente sterilizzata dal vento solare e la sua atmosfera sarebbe molto più sottile. Forse una vita batterica potrebbe essere ancora possibile, magari sotto la superficie al riparo dalla radiazione, ma per fortuna, per noi, questa è solo speculazione.
La sorprendente risposta è che perché possa esistere un nucleo di ferro liquido necessario a produrre le enormi correnti elettriche per generare un campo magnetico analogo a quello terrestre esiste un limite ben definito: all’incirca attorno alle due masse terrestri.
Oltre questo limite le pressioni e le temperature del nucleo non sembrerebbero consentire l’esistenza di un nucleo di ferro allo stato liquido, anche se è importante sottolineare che le impurità nella composizione chimica, le dimensioni, il tasso di decadimento del calore, etc… possono alterare le condizioni fisiche necessarie per garantire la necessaria fluidità del nucleo capace di generare un campo magnetico.
Quindi scopriamo che che ci possono essere dei seri limiti fisici per i pianeti adatti ad ospitare forme di vita sulla superficie come il nostro: non solo è necessario che il pianeta orbiti all’interno di una zona Goldilocks attorno alla stella che permetta l’esistenza dell’acqua allo stato liquido, ma che anche le dimensioni di questo siano racchiuse in un arco abbastanza ben definito per ospitare un nucleo di ferro fuso capace di sprigionare un campo magnetico protettivo importante.