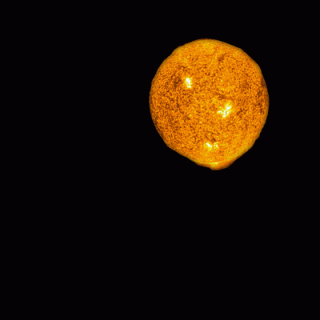Questo articolo nasce in seno alla preparazione del materiale di studio per lo stage per i finalisti delle Olimpiadi di Astronomia 2016 presso l’INAF-Osservatorio Astrofisico di Asiago due lezioni, tra le tante, dedicate interamente ai pianeti extrasolari. Sabrina Masiero e il sottoscritto hanno studiato e rivisto i calcoli, più volte, perciò fidatevi!
 Ogni volta che sentiamo parlare della scoperta di qualche nuovo pianeta in orbita attorno a qualche stella, viene spontaneo chiederci se esso può ospitare una qualche forma di vita. La vita come la conosciamo ha bisogno di acqua allo stato liquido per poter esistere, e poter stabilire i limiti dove questo è possibile è di notevole importanza. Questa zona è chiamata Goldilocks o Riccioli d’Oro 1 perché ricorda la bambina della favola, Goldilocks appunto, quando deve scegliere tra le tre ciotole di zuppa, quella che non sia né troppo calda né troppo fredda, giusta.
Ogni volta che sentiamo parlare della scoperta di qualche nuovo pianeta in orbita attorno a qualche stella, viene spontaneo chiederci se esso può ospitare una qualche forma di vita. La vita come la conosciamo ha bisogno di acqua allo stato liquido per poter esistere, e poter stabilire i limiti dove questo è possibile è di notevole importanza. Questa zona è chiamata Goldilocks o Riccioli d’Oro 1 perché ricorda la bambina della favola, Goldilocks appunto, quando deve scegliere tra le tre ciotole di zuppa, quella che non sia né troppo calda né troppo fredda, giusta.
Calcolare le dimensioni e ‘estensione della fascia di abitabilità di una stella ci permette di capire quanto debba essere grande l’orbita di un pianeta per essere potenzialmente in grado di sostenere la vita.
Per comodità di calcolo verranno qui usati i parametri del nostro Sistema Solare ma conoscendo il flusso energetico (ossia la temperatura superficiale) di una qualsiasi stella e il suo raggio, allora sarà possibile usare questi nei calcoli che qui presentiamo purché si usino le stesse unità di misura.
- Temperatura superficiale del Sole T⊙ 5778 Kelvin
- Raggio del Sole in unità astronomiche R⊙ 6,96×1005km1,496×1008km=4,652×10−03AU
- Distanza dal Sole in unità astronomiche a
- Albedo del pianeta A (nel caso della Terra è 0,36)
Come spiegato anche nell’illustrazione qui accanto il flusso luminoso, e quindi ovviamente anche la temperatura, obbedisce alla semplice legge geometrica dell’inverso del quadrato della distanza.
La luminosità di una stella non è altro che la quantità di energia emessa per unità di tempo e considerando una stella come un corpo nero perfetto, si trova che L⊙=4πR⊙2σT⊙4, dove σ è la costante di Stefan-Boltzmann.
Pertanto un pianeta di raggio Rp in orbita alla distanza a dalla sua stella di raggio R⊙ riceve una certa quantità di energia che riemette nello spazio come un corpo nero e raggiungendo perciò un equilibrio termico con il flusso di energia ricevuto. πRp24πa2=(Rp2a)2
Il pianeta offre solo metà di tutta la sua superficie alla stella (2πRp2), per questo si è usato questa forma, perché il flusso intercettato è pari alla sezione trasversale del pianeta (πRp2), non tutta la sua superficie, mentre invece tutta la superficie del pianeta, quindi anche la parte in ombra, è coinvolta nella riemissione di energia (4πRp2).
Una parte del’energia ricevuta dal pianeta viene riflessa comunque nello spazio in base al suo indice di riflessione (fosse idealmente bianco la rifletterebbe tutta così come se fosse idealmente nero l’assorbirebbe tutta); questo indice si chiama albedo A e varia di conseguenza tra 1 e 0. La forma “1−A” consente di stabilire quanta energia è quindi assorbita da un pianeta: (1−A)×4πR⊙2σT⊙2×(Rp2a)2
Semplificando il tutto e eliminando per un attimo anche la superficie della sezione trasversale del pianeta, quasi insignificante come contributo al calcolo, si raggiunge questo risultato: Teq4=(1−A)T⊙4(R⊙2a)2 Teq=(1−A)1/4T⊙√(R⊙2a)
Se usassimo questi valori per la Terra usando come è stato detto le lunghezze espresse in unità astronomiche otterremo: Teq=(1−0,36)1/4⋅5778√(4,625×10−032⋅1)=249K
Purtroppo non è dato sapere a priori l’albedo di un qualsiasi pianeta, esso varia infatti col tipo e composizione chimica dell’atmosfera e del suolo di un pianeta, per questo può risultare conveniente omettere il computo dell’albedo nel caso di un calcolo generale senza per questo inficiarne nella bontà, un po’ come è stato fatto anche per la superficie del pianeta prima. Così la formula può essere riscritta più semplicemente come Teq=T⊙√(R⊙2a)
Se ora volessimo calcolare entro quale intervallo di distanza dalla stella vogliamo trovare un certo intervallo di temperatura potremmo semplicemente fare l’inverso per aver il risultato espresso in unità astronomiche:a=12(T⊙Teq)2R⊙
Per trovare un intervallo di temperature compreso tra 240 K e 340 K nel Sistema Solare dovremmo andare tra i 1,35 e 0,67 AU.
Perché ho usato questo strano intervallo di temperature pur sapendo che alla pressione canonica di 1 atmosfera l’acqua esiste allo stato liquido tra i 273 e i 373 K?
Semplice 2! Ogni pianeta possiede una sua atmosfera (ce l’ha anche la Luna anche se questa è del tutto insignificante) che è in grado di assorbire e trattenere calore, è quello che viene chiamato effetto serra. L’atmosfera della Terra ad esempio garantisce a seconda dei modelli presi come riferimento da 15 a 30 e più gradi centigradi di temperatura in più rispetto alla temperatura di equilibrio planetario, consentendo così all’acqua di essere liquida pur restando ai margini superiori della zona Goldilocks del Sole.
Aggiornamento
Non riporterò questo aggiornamento di stato nel sito Tutti Dentro dove questo articolo è uscito in contemporanea a qui. Questa aggiunta è mia e me ne assumo ogni responsabilità verso i lettori per quello che sto per scrivere.
| [table id=70 /] |
Forse non è stato compreso bene che nonostante il ruolo dell’albedo sia importantissimo nel calcolo esatto per stabilire se una precisa orbita cade all’interno di una zona Goldilocks, esso purtroppo è un dato che non è possibile stabilire per adesso nel caso dei pianeti extrasolari. Si possono considerare un ampio spettro di possibilità, diciamo tra un albedo di 0,99 e 0,01, indicare un valore medio tra questi due oppure scegliere tra uno de valori che sono suggeriti in questa tabella o oppure ancora si può scegliere di non usare affatto l’indice albedo in questa fase di calcolo, come ho fatto deliberatamente io in questa fase. Dopotutto si deve stabilire un discreto intervallo di possibili orbite di un pianeta di massa non bene definita su un ampio intervallo di possibili temperature di equilibrio attorno ad una stella lontana.
Prendiamo ad esempio il Sistema Solare visto da una manciata di parsec e si supponga fosse stato possibile identificare sia Venere che la Terra, di conoscere la loro distanza e il loro albedo.
Applicando l’equazione sprovvista del computo dell’albedo qui sopra (12(T⊙Teq)2R⊙) , essa restituisce una temperatura di equilibrio, che per Venere sappiamo essere di 253 kelvin, di 327 K, ma che corretta per l’albedo, ossia: a=12(T⊙Teq)2R⊙√1−A dà esattamente il valore corretto. Un errore del 29% in più ma che per albedo inferiori tende quasi ad annullarsi.
Un altro metodo che era stato proposto e fatto passare come l’unico valido a=√1−A2R⊙(T⊙Teq)2 sembra esattamente equivalente allo stesso metodo corretto per l’albedo qui suggerito (12(T⊙Teq)2R⊙√1−A), ma si dimostra essere del tutto fallace se usato senza tenere conto dell’albedo; con lo stesso esempio precedente si arriva a definire la temperatura di equilibrio di Venere a 462 K, l’83% in più.
Sono piccolezze, è vero, e di solito non amo polemizzare – anche se qualcuno potrebbe pensare il contrario – e ammetto che non sono un gran genio nella matematica, di solito faccio dei casini enormi nelle semplificazioni (ma non in questo caso). Ma amo sperimentare, rifare i calcoli decine di volte prima di scriverli e pubblicarli, per cui quando lo faccio so che sono corretti e testati decine di volte come in questo caso.
Ho scelto di offrire il mio modesto aiuto a una cara amica per questo appuntamento e scoprire che presuntuosamente veniva affermato che questo lavoro era sostanzialmente errato non l’ho proprio digerito. Con questo stupido esempio ho voluto mostrare la bontà di questo lavoro che consente a scapito di un lieve margine di errore di poter essere usato anche senza tener conto dell’albedo di un pianeta; ho scelto Venere perché avendo l’albedo più elevata era quello che più avrebbe messo in difficoltà il procedimento descritto in questo articolo (se avessi usato la Terra avrei avuto un 12% a fronte di 58%).
Quindi il mio invito è quello di non raccattare formule a caso qua e là sulle pubblicazioni più disparate e spacciarle per buone senza averle prima provate, smembrate e ricomposte; qui l’errore è evidente, non serve molto per vederlo. Potreste dire poi delle castronerie che prima o poi si rivelano per quel che sono: ciarpame.