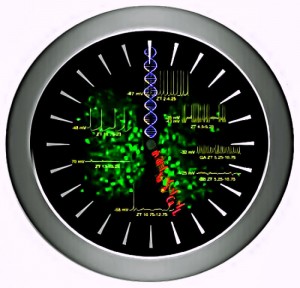Solo poche ore fa in un convegno scientifico di geofisica svoltosi a Firenze è stata presentata l’ipotesi che la vita sulla Terra abbia avuto piuttosto origine su Marte. Molti altri blog hanno ripreso la notizia come oro colato, ma non credo che sia così.
L’interscambio di materiale tra i pianeti del Sistema Solare in sé è, almeno in un senso, ampiamente provato, come i resti di antichi frammenti marziani rinvenuti sulla Terra mostrano 1 .
La teoria ora proposta a Firenze da Steven Benner 2 alla conferenza di geochimica Goldschmidt vuole che le condizioni passate su Marte siano state molto più favorevoli alla vita che sulla Terra, e che da lì, una volta sviluppata, la Vita – o più probabilmente i suoi precursori – sia finita sulla Terra attraverso il medesimo meccanismo meteorico.
La teoria di Benner parte dall’ipotesi che la Vita quale la conosciamo abbia avuto origine da molecole di RNA 3 e che alcuni metalli, il molibdeno 4 5 e il boro, abbiano avuto un ruolo determinante nella stabilizzazione delle prime molecole organiche nella sua forma altamente ossidata.
Diversi esperimenti mostrano infatti che il molibdeno e il boro, in forma di composti altamente ossidati, sono dei catalizzatori cruciali per la formazione delle molecole di RNA [cite source=’pubmed’]11906160[/cite] [cite source=’pubmed’]21221809[/cite]. Ad esempio, i catalizzatori a base di boro aiutano a stabilizzare le molecole di zucchero composte da cinque atomi di carbonio mentre i catalizzatori a base di molibdeno riorganizzano questi zuccheri in ribosio. Inoltre, l’abbondanza di acqua nella Terra primordiale avrebbe impedito la formazione delle molecole di RNA 6 e la sostanziale assenza di ossigeno atmosferico avrebbe impedito la stabilizzazione del boro in borati 7 e dei catalizzatori di molibdeno.

Il meteorite MIL09000 ritrovato in Antartide nel 2010. Si ritiene che abbia circa 700 milioni di anni.
Credit: Johnson Space Center /NASA
A sostegno delle idee di Benner sono la scoperta di argille ricche di boro in un meteorite marziano, MIL 090030 [cite]10.1371/journal.pone.0064624[/cite] [cite]10.1111/j.1945-5100.2012.01420.x[/cite] e la straordinaria scoperta della ricca presenza di ossigeno nel mantello marziano almeno 3,7 miliardi di anni fa [cite]10.1038/nature12225[/cite].
Un ambiente ricco di ossigeno (il mantello marziano), il boro (nelle argille marziane) e il molibdeno sono essenziali – secondo Benner – per la nascita e lo sviluppo di molecole di RNA, precursori di ogni altra forma di vita, e il primitivo Marte molto probabilmente lo era.
Per contro – e pare assurdo – le condizioni ambientali terrestri di quando si presume si siano formate le prime forme di vita 2-3,5 miliardi di anni fa, sono molto scarse a causa della dinamicità geologica del pianeta e resti più antichi di 3,8-4 miliardi di anni sono molto difficili da trovare e studiare 8. Per questo non sappiamo esattamente quali siano state le condizioni chimico-fisiche presenti sulla Terra alla fine dell’Adeano [cite]10.1038/nature10655[/cite] [cite]10.1038/nature11679[/cite] e se la Terra era umida quanto oggi o se, più probabilmente, molta acqua e ossigeno erano ancora intrappolati nel mantello superiore. 4 miliardi di anni fa il Sole era un po’ più debole di oggi e solo un massiccio effetto serra prodotto da una atmosfera satura di anidride carbonica e vapore acqueo scaldava il pianeta. Magari le condizioni auspicate per l’ipotesi marziana (molibdeno, boro e ossigeno) erano comunque presenti nel sottosuolo terrestre che offriva condizioni fisiche (temperatura, pressione etc.) piuttosto stabili e al riparo dalla radiazione ultravioletta del Sole che, in assenza di una barriera di ozono, sterilizzava la superficie del pianeta.
Finora le prove di Benner confermano che sul Pianeta Rosso sono esistite in un lontanissimo passato le condizioni favorevoli allo sviluppo della Vita secondo la teoria del Mondo a RNA. Ma ci sono altre teorie, che mi riservo di spiegare più a fondo in seguito, che in assenza di prove contrarie meritano di essere altrettanto prese in considerazione. In attesa, o in assenza, di prove più concrete sull’origine marziana della Vita terrestre o dei suoi precursori, credo che sia opportuno continuare ad indagare e a supporre – per il momento – che la Vita sulla Terra sia autoctona 9.
Quindi perché scomodare il vulcanismo marziano o un impatto meteorico su Marte che ha scagliato RNA marziano qui dopo un viaggio di un paio di milioni di anni? Per me significa solo spostare lo storico dilemma.